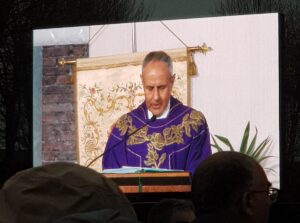Attraverso le circostanze

Ugo. Abbiamo il regalo di avere con noi Julián[1] e quindi iniziamo subito. Leggo una frase che lui ha detto l’altro ieri, in occasione di un incontro sul Natale fatto alla Fondazione San Michele Arcangelo: «A noi interessa capire sempre di più la portata delle circostanze in cui siamo chiamati a vivere la vita, la vita come vocazione. E che cos’è la vocazione per poter capire la portata delle circostanze, per poter camminare al destino? “Vivere la vocazione – dice Giussani – significa tendere al destino per cui la vita è fatta. Tale destino è Mistero, non può essere descritto e immaginato. È fissato dallo stesso Mistero che ci dà la vita”. Dunque, il destino non lo decidiamo noi. Qual è, allora, il destino che il Mistero che ci dà la vita ha fissato per noi? Il nostro compimento, la nostra felicità. Il Mistero non ci ha creato per altro scopo che per raggiungere la felicità!
“Vivere la vita come vocazione significa tendere al destino, al Mistero, attraverso le circostanze in cui il Signore ci fa passare, rispondendo ad esse […]. La vocazione è quindi andare al destino abbracciando tutte le circostanze attraverso cui il destino ci fa passare”. (L.G. Realtà e giovinezza. La sfida, Rizzoli, pagg. 64-65).
Giussani, come vedete, sottolinea che la vocazione esiste non “nonostante” le circostanze, non si realizza “nonostante” le circostanze, ma proprio attraverso di esse. Ogni situazione, ogni incontro, ogni sfida che la realtà ci pone – e sono tante – è un’occasione per scoprire e vivere il nostro destino, il nostro compito nella vita. Nulla, dunque, è da scartare». Questa prospettiva mi entusiasma, non perché mi senta adeguato, ma come possibilità per la vita. Tutto fa parte del cammino, se noi usiamo tutto ciò che accade per camminare verso il destino. A noi però, sembra che non sia così! Sembra spesso che non tutte le circostanze siano occasione, ma solo alcune! A noi pare che alcune siano da scartare.
Julián. Salve a tutti, buonasera. È sempre un piacere vedersi. Proprio questo è quello che occorre capire, perché potrebbe sembrare una frase dipinta sul muro, detta così. Perciò, se la prima provocazione della realtà che non ci torna, diciamo: «Questa circostanza è da scartare». Invece, tutto il percorso che ho fatto l’altro ieri è per mostrare come qualsiasi circostanza, se uno la asseconda fino alla fine, porta al compimento; «Vivere intensamente il reale», come è scritto nel capitolo decimo de Il senso religioso su cui stiamo lavorando, senza scartare niente.
Intensamente non vuol dire vivere con non so quale atto volontaristico, o quale sforzo meccanico, non vuol dire stringere i pugni con forza! Vuol dire non fermarsi, fino a quando si scopre come le circostanze sono decisive per la vocazione. Questo è quello che cambia tutto, perché quando si vedono persone che assecondano la provocazione delle circostanze – e abbiamo tanti tra di noi che ce lo testimoniano – si scopre che la gente fiorisce e non si lamenta! Altri, invece, nelle stesse circostanze, si lamentano in continuazione. Quindi, ci conviene andare a fondo delle circostanze! Se non le capiamo, sembra che le circostanze siano ostacoli – come diceva il testo che è stato letto adesso -; invece, non “nonostante” le circostanze, ma attraverso di esse. Avendo dei figli, voi potete vedere che il figlio è la testimonianza più solare e più semplice per osservare che ciò che ha appena letto è vero; per il figlio qualsiasi circostanza – piangere, aver fame, aver paura, sentire la mancanza di qualcosa – non è un ostacolo a vivere, ma è un’occasione strepitosa perché, attraverso essa, può stare in rapporto col padre e la madre. Qualcuno osa negare questa evidenza che, in ogni istante, si vede nel rapporto con i figli? Se le cose stanno così – e lo vediamo nei figli – vuol dire che può essere così anche per noi. Il problema è che, per questo, occorre diventare figli, occorre diventare come bambini, dice Gesù; noi non crediamo che quel che dice Giussani sia vero. Quindi ci perdiamo, ci incastriamo costantemente in tanti problemi, che, invece di essere un cammino al destino, diventano un inciampo! Ma non perché siano un inciampo. È come se un figlio, quando ha paura, si incista nella paura e, invece di andare dai genitori, sta fermo a dire: «Ho paura, ho paura, ho paura…». Oppure quando ha fame, invece di usare la fame per rivolgersi ai genitori, si blocca. E voi che cosa gli direste per andargli incontro: «Ma non vedi che sono qui?».
La circostanza è l’occasione per entrare in rapporto. È facile! Altrimenti il cristianesimo non sarebbe per me. E non sarebbe cristianesimo! Invece il cristianesimo è per tutti! È alla portata di tutti. Il problema è che abbiamo proiettato sul cristianesimo qualcosa che cristianesimo non è, perché il cristianesimo è quello che si vede nei figli. Per questo Gesù prendendo un bambino, e ponendolo in mezzo ai discepoli, diceva: «Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». La vita si moltiplica di intensità, si potrà vivere cento volte meglio tutto! L’esempio del bambino è l’esempio del vivere, non perché il bambino non sbagli in continuazione: sbaglia, inciampa, ma costantemente ritorna dal padre e dalla madre e qualsiasi situazione può essere l’occasione per il rapporto con loro. Se si imparasse dai figli, tutto sarebbe più facile. Questo è il significato semplice – come vedete, a portata di mano dei bambini – ma profondissimo di questa frase di Giussani: «Noi camminiamo al destino attraverso le circostanze». Noi camminiamo al rapporto con il destino, cioè con Cristo, attraverso le circostanze. Quando il bambino accetta di vivere come figlio e non come orfano pur avendo i genitori, si vede che la vita è molto meglio. Se però noi preferiamo vivere come orfani, allora la vita diventa complicata, molto più complicata. Non è che uno decida di vivere come orfano perché non ha i genitori, tutti abbiamo genitori; alzi la mano che non ce li ha! Quindi, tutti possiamo andare al destino attraverso le circostanze, come i bambini, perché Lui ci ha fatti così spalancati che, solo assecondando le circostanze come i bambini, possiamo raggiungere lo scopo per cui siamo fatti. Le circostanze però non funzionano meccanicamente. Il bambino può avere fame, questo sì è qualcosa che nasce un po’ naturalmente, o può avere paura, ma lui può decidere di incastrarsi, o può decidere di usare quella paura per cercare un altro. E qui si gioca tutta la partita.
Intervento. Voglio raccontarti e raccontarvi quello che mi sta succedendo. Una settimana fa ho saputo di avere un tumore ai polmoni; non immaginavo che potesse riaccadermi. La prima volta, non appena mi è stato detto che avevo il tumore, ho fatto un po’ il bilancio sulla vita: ho vissuto poco, male e così via. Invece il Signore mi ha riempito di certezza e ne è nata tutta una storia di certezza. Questa volta, venivo da un periodo in cui mi accorgevo sempre di essere molto arida, quando mi è stato detto del tumore, mi è venuto immediato dire: «Magari ci vediamo presto». Ciò mi ha molto stupito e mi son detta: «Caspita! È impressionante che Lui mi prediliga, tanto da potergli dire: “Magari ci vediamo presto”». L’altro aspetto che mi ha colpito è che ho percepito questa circostanza come l’«essere visitata», perché il tumore è parte di me, ma non me lo do io, è un’inesorabile presenza. Mi ricordo che tempo fa tu hai detto che la circostanza non solo è una presenza, ma è inesorabile. Questa inesorabilità, invece di darmi oppressione, è stata una liberazione. Perché la circostanza è di un Altro. Io ho un po’ la testa dell’assistente sociale, che deve tentare sempre di risolvere i problemi, sono stata formata così. In questo caso, invece, nel quale non ho più niente da fare, provo una grande liberazione! Mi viene in mente che don Gius., quando era ammalato, mi ha detto: «Vedi, io adesso non posso più parlare con te, perché non ho più forza. Ma io sono proprio contento (nonostante tutta la sua fatica di dover accettare la condizione) perché io adesso obbedisco. Tutta la vita ho sempre avuto paura di non obbedire, adesso che sono in una circostanza inevitabile, sono lieto». In quel momento ho capito che cos’è la libertà: è l’essere di fronte a una presenza inesorabile. Io non ho più niente da fare, se non seguire uno che mi ha visitato. E questo mi colpisce molto.

Foto d’archivio
Intervento. Parto da un episodio che è capitato a me e a mia moglie. Una coppia, marito e moglie, che hanno una figlia che fa pallavolo con una delle nostre figlie, un giorno ci chiama dicendo: «Guardate, avremmo bisogno di prendere un caffè con voi». Andiamo all’appuntamento e loro ci raccontano che con il primo figlio la situazione è pesantissima: il ragazzo è totalmente fuori controllo, è anche un po’ violento, e, nel paese dove vivono ha iniziato a seguire brutte compagnie. Loro, preoccupatissimi, ci dicono: «Voi – vi abbiamo osservato – avete dei figli che sono bravi; cerchiamo allora di agganciarli con i nostri, in modo tale che lui possa riprendersi. Vediamo che hanno un’amicizia, un ambito, che vanno all’oratorio». Io, rispetto alla frase «sono bravi, hanno un ambito…», ho pensato che a un incontro a Treviglio, tu hai parlato di «bolla». Perché, in realtà, negli ultimi anni, ognuno dei miei figli, in maniera diversa, per motivi e situazioni diverse, ha mostrato una fragilità infinita davanti alla vita e a circostanze che si sono rivelate dure. Ciò ha stupito e preoccupato me e mia moglie e mi ha fatto dire: «Caspita! Non pensavo che fossero così fragili». Allora, parlando dei figli anche con amici che sono qua, la cosa che io ho in mente è che non è tanto un problema dei figli, ma innanzitutto un problema mio: la loro felicità è sulla stessa strada della mia felicità e quindi come posso io essergli di aiuto? Posso essergli di aiuto se io vado a fondo di quello che ho visto, di quello che ho incontrato e che risponde a quel desiderio di felicità che ho, facendomi però, a Dio piacendo, fare le cose con letizia, nonostante le difficoltà. In un altro incontro che tu hai fatto a Pescara, verso la fine, la relatrice, quasi a tradimento, ti domanda: «Hai davanti tanti ragazzi, cosa auguri loro? Di essere liberi o ribelli?».
Commentando questa domanda, un amico mi ha detto: «Io avrei detto liberi»; io, sinceramente, senza fare il fenomeno, ho detto di me: «Beh, quasi liberi, abbastanza liberi, più o meno liberi», invece tu, di schianto, hai detto: «Ribelli, nel senso vero del termine, vale a dire che non si accontentino con meno di tutto quello che il cuore desidera, perché questo è quello che li renderà veramente liberi». Tu qua fai un un’affermazione che io non riesco a cogliere, o, comunque sia, nel concreto, non riesco a capire.
Julián. Molte volte sappiamo che concetto c’è davanti a questa alternativa. E io non ho mollato su questo. Non è che io, quando dico «ribelli», sto dicendo «che facciano i cavoli loro». Dico che viviamo in uno status quo nel quale la gente si accontenta con qualsiasi cosa! E dire «ribelli» in quel contesto, è come dice Giussani: «Vi auguro di non essere mai tranquilli!». Infatti, solo chi non si accontenta, solo chi non è mai tranquillo, potrà raggiungere la libertà. Colui che non si accontenta con meno di tutto quello che il cuore desidera e si ribella a qualsiasi tipo di riduzione di sé, è l’unico che potrà veramente incontrare qualcosa che corrisponda all’attesa del cuore, che è la soddisfazione! È quello che abbiamo visto nel capitolo settimo e ottavo de Il senso religioso, che si chiama «libertà»: la libertà è il compimento del desiderio. È questa la questione decisiva che tante volte noi non capiamo; il più delle volte, noi vogliamo figli adeguati, che non facciano casino, che non siano se stessi. Così noi stiamo più tranquilli, diciamoci la verità. Così tante volte preferiamo un figlio che sia sempre in ordine, piuttosto che un altro che abbia qualcosa che lo fa ribollire dentro.
Ma, se io non fossi stato ribelle, in qualche modo, anche dentro un certo ordine – ve l’ho detto tante volte – se io non avessi assecondato la mia umanità, non saremmo qua. Perciò, il problema è che cosa intendiamo con certe parole, se siamo veramente leali con quel dono che il Mistero ci ha dato – come diceva il testo che abbiamo letto prima – perché il destino non lo decidiamo noi! Non decidiamo noi la tensione alla pienezza e al compimento; è qualcosa con cui siamo stati fatti. Quindi, “essere ribelli” è esserlo davanti a qualsiasi tentativo del potere, perché qualsiasi tipo di potere tenta di abbassare il livello dell’esigenza di pienezza, ed è quindi contro l’umanità dell’uomo. E contro i figli. Poiché Dio ha pazienza con noi, anche noi dobbiamo imparare la pazienza con i figli, con i ragazzi che troviamo, perché, solo se loro “ribollono”, potranno non accontentarsi con meno. Quelli che si accontentano con meno, alla fine saranno poveracci, disgraziati, perché non si troveranno mai a loro agio. Tutti abbiamo in mente la parabola del figlio prodigo: il fratello si è adeguato, anche se è stato nella casa del Padre lamentandosi.
Non ha rischiato niente, non ha rotto un piatto; ma è il tipo di vita che vogliamo? Vivere in casa da servo, in fondo? O rischiare anche di sbagliare, per poter verificare la differenza tra i miei tentativi maldestri e il rendermi conto di che cosa vuol dire avere un padre grazie al quale la vita si compie? Noi vogliamo saltare costantemente il passaggio della libertà. Non possiamo – abbiamo sempre detto – arrivare al destino per cui il Mistero ci ha fatto, se non attraverso la libertà! E a noi fa fare molta fatica il passare “attraverso la libertà”. Per il Mistero sarebbe stato facilissimo e gli sarebbe costato molto meno, generare un altro essere che compisse perfettamente le regole della natura, come ha fatto con gli astri, o con i passeri o con i cani: un altro in più…, perfetto! Ma ha preferito avere uno che gli volesse bene liberamente. Voi no? E non è che occorre, come dico sempre, essere molto intelligenti o essere Dio per rendersi conto che, se uno genera un essere libero, qualche inconveniente può nascere. Ma se non siamo i primi a tifare per il cammino dei nostri figli, o per il cammino di ciascuno di noi, anche zoppicando, anche a tentoni, anche con tentativi ironici, il cammino non sarà mai loro, perché «non si può andare al destino – dice Giussani – se non attraverso la libertà». Se non andassimo al destino attraverso la libertà, non sarebbe una felicità nostra, mia, di ciascuno di noi! Da ultimo – questo è un altro passaggio fondamentale di quello che abbiamo detto riguardo alle circostanze – è un momento in cui siamo sfidati e, se non andiamo a fondo per capire che questo passaggio è decisivo per noi, per i nostri ragazzi, per i giovani di ogni latitudine, non capiamo cosa voglia dire essere ribelli! E, allora, interpretiamo alla rovescia, e vogliamo persone formalmente a posto. Questo «formalmente a posto», però, non vuol dire il compimento, non sarà mai il compimento; è semplicemente un accontentarsi con meno di quello che il cuore desidera. Tutto ciò è troppo poco per la capacità dell’animo, dice Lopardi. E quando uno non ha trovato quello che è adeguato alla sua capacità, è sempre irrequieto. Per questo, se confondiamo questa irrequietudine con una sorta di ribellione, lo diciamo sbagliando totalmente. “Ribelli” vuol dire assecondare questa irrequietudine, perché il Mistero ce l’ha messa dentro le viscere, anzi sta spingendo ogni istante dal di dentro! Noi diamo per scontato il desiderio, l’irrequietudine, ma se il Mistero non sollecitasse in continuazione, saremmo già tutti con l’encefalogramma piatto! Noi ci ribelliamo contro questo desiderio, ma senza questo desiderio, senza questa irrequietudine, che cosa sarebbe la vita? Si vivrebbe sempre meno, e quindi sarebbe la noia assoluta. Perciò, non so se ci conviene avere l’idea che noi abbiamo: «Sarebbe stato meglio se ci avesse fatto diversamente».
È difficile trovare un ordine migliore di quello che il Mistero ha fatto. Dobbiamo fare una correzione alla totalità del disegno, perché non ci torna… Ma basterebbe, come vi dico sempre, che non avesse creato la libertà: tutto sarebbe andato perfettamente. Tutto meccanicamente, secondo le leggi fisse della fisica. Ma questo sarebbe umano? Se noi, in ogni attimo, non partiamo, come tu hai fatto, dalla circostanza che provoca, o che infastidisce, o che non torna, per approfondire la natura delle circostanze stesse, per poterle percepire come parte essenziale del cammino al destino, esse sono una palla al piede. Invece, quando uno le comprende, possono essere faticose, possono essere a volte anche spiacevoli come quella che diceva poco fa la nostra amica, ma fanno parte del cammino al destino. Infatti, il destino usa di una malattia che porta a dire: «Ma io perché sono fatto?».
Quante persone, attraverso una provocazione simile, recuperano la vita! Noi senza drammi, in fondo, perdiamo la vita vivendo! Allora, le circostanze perché sono essenziali? Perché sono una provocazione costante al nostro desiderio di encefalogramma piatto. Ma questo non c’entra niente, ma niente, niente – io ve lo regalo tutto – con il compimento.
Centuplo quaggiù
Intervento. Voglio raccontare un episodio su questo. Alludo all’incontro di cui si parlava prima, quello di Treviglio. Quella sera un amico mi ha avvisato che ci sarebbe stato, ma io non potevo venire, perché avevo invitato a cena delle persone a casa mia. E, appena mi è stato detto, sapevo che queste persone non sarebbero venute all’incontro. Ho sentito mia moglie e le ho detto: «Facciamo saltare la cena e io vado a Treviglio». Iniziamo a messaggiarci e, a un certo punto, lei mi scrive: «Stai sereno, il quotidiano basta e avanza. Cosa hai paura di perdere?». Poiché su questo mi sono sempre scontrato con lei, questa volta invece sono stato costretto a dire: contropiede, 1 a 0 palla al centro: «Andiamo a vedere se è così», il che sembra contraddittorio con la dinamica del desiderio. Dire «guarda che il quotidiano basta e avanza» sbalordisce, soprattutto quando si pensa: «Ecco, ma sono sempre le stesse routine, sempre la stessa strada che si fa per andare al lavoro, sempre le stesse attività». Invece, in ciò che tu dici, sto scoprendo che alla fine si gioca tutto in una opzione non solo della libertà, ma anche della ragione. Cioè, «andiamo a vedere se c’è qualcosa!». Quindi, mi accorgo, per esempio, della collega a cui è morto il figlio tre anni fa, a cui ho chiesto: «Quando diciamo la Messa per lui?». E lei si stupisce che gliel’abbia chiesto, perché mai nessuno in tre anni gliel’ha chiesto, né tra i colleghi, né tra i parenti. E io mi stupisco a mia volta, perché lei si è stupita. È così che si gioca la dinamica del desiderio?
Julián. Assolutamente. Perché tu hai detto questo alla tua collega? Perché tu, avendo colto la portata di quello che ha significato per lei questa vicenda, hai preso iniziativa con lei. Poi, la verifica di quello che succede in certi momenti, si fa, come dice tua moglie, nel quotidiano. Certi momenti sono come un paradigma, ma poi il paradigma occorre verificarlo nel quotidiano, perché Gesù dice: «Chi mi segue avrà il centuplo quaggiù»; non dice qualsiasi circostanza, ma dice che nella vita tutto diventa cento volte tanto. In questo senso, il problema è se quello che viviamo, verificato nel quotidiano, ci fa capire che cosa vuol dire il centuplo nel quotidiano che normalmente taglia le gambe! Perché, altrimenti, saltiamo di palo in frasca, un incontro dopo l’altro, ma non si arriva mai a toccare la trama quotidiana del vivere, perché possa diventare sempre più nostro. Per questo diceva Giussani: «Non aspettatevi un miracolo, ma un cammino!», che ogni passo della vita sia un cammino, sia il passo di un cammino; e il cammino si fa, passo dopo passo, nel quotidiano. Quindi, quello che uno vive come momento decisivo, occorre poi verificarlo nell’esperienza, perché è in essa che giunge la convinzione! Tante persone fanno cose straordinarie: vanno a fare un viaggio, vanno a fare una gita, realizzano un’immagine che hanno in testa, ma tutto ciò, quando occorre affrontare il quotidiano, è inutile. Infatti, come ciascuno sa, la verifica delle vacanze è il primo giorno di lavoro dopo le vacanze.
Una persona verifica se ha voglia di mettere le mani in pasta, se ha avuto una esperienza tale del vivere per cui desidera alzarsi di nuovo al mattino, con la coscienza che la vita gli è stata data, che il tempo gli è stato dato, che le sfide gli vengono date, per verificare se quello che ha scoperto in un momento delle vacanze, regge anche nel quotidiano! Diversamente, nel tempo diventiamo scettici. Alla fine, va bene, ci vediamo, siamo contenti, è piacevole l’occasione, ma se poi il quotidiano non cambia, diciamo: «Vedi? Tutto è qualcosa che non lascia traccia». Per questo occorrono sempre le due cose: la prima, qualcosa che ci ridesta, poi se quello che viviamo in certi momenti, si ripercuote sulla vita, perché quello che veramente convince è la verifica nella vita. Altrimenti, la prossima volta che andiamo in un posto e si ridesta qualcosa in noi, dopo qualche giorno, tutto di nuovo finisce. Quindi, questo è decisivo per capire che non solo certe circostanze valgono, ma tutte le circostanze! Ce ne sono alcune particolarmente rilevanti che ti introducono al reale, ma poi si deve verificare in ogni circostanza che la vita non ci risparmia, perfino in una sfida, come ci diceva prima la nostra amica, come la malattia.

Foto d’archivio
Intervento. La settimana scorsa mi è capitato che un mio collega si è sposato con un uomo. E ci ha invitato a festeggiare con lui; la decisione di andare non è stata proprio naturale. In realtà poi, con una mia amica, anche lei del movimento, sono andata ed entrambe siamo state contente di essere andate per lui. Però, è tutta la settimana che ho questa domanda rispetto a lui: di non guardare la sua unione come fosse una cosa normale, a cui ormai siamo tutti abituati, essendo circondati da situazioni analoghe; e neanche di guardarlo come quella che lo giudica e dice: «Quello che stai facendo non è secondo i nostri canoni», perché non è un matrimonio, ma un’unione civile. Però, a me interessa poterlo guardare per quello che è lui. Julián. Tutti avete presente la Samaritana? Quanti mariti aveva? E Gesù che cosa guarda?
Intervento. Il suo desiderio.
Julián. Il suo desiderio, la sua sete. Lui non nega lo sbaglio e la rende anche consapevole, ma non si confonde su qual è il vero desiderio di quella donna. Tant’è vero che appena glielo accenna, lei dice: «Dammi di quest’acqua». La vera questione è che Lui prende la persona nel punto in cui è, ma non resta solo a una parte della persona, perché sa che la persona non coincide con i propri sbagli, è sempre qualcosa in più degli sbagli. E se noi riduciamo la persona allo sbaglio, stiamo sbagliando noi. Quindi, uno deve guardare la persona per tutta la pienezza di desiderio a cui è chiamata. La sfida, una volta che è successo questo, non è diversa per quello con cui è sposato legalmente. La sfida è se con l’uno o con l’altro noi siamo talmente consapevoli di cosa viviamo. E chi ci dice che costui, con tutta la sua drammaticità, non sia più in subbuglio dell’altro che ha tutto a posto? Chi lo può dire? A noi che cosa corrisponde? A noi che cosa viene chiesto? Di guardare l’altro, come fa Gesù con quella donna, per quello che è! Il resto sarà problema suo. E chissà se tu, vivendo questa situazione che ti sfida, per poter stare davanti a lui, hai bisogno di una tale intensità di memoria, che non ti fa dimenticare che l’altro non può essere ridotto agli sbagli. E quindi hai bisogno di crescere tu nella coscienza di che cosa vuol dire essere uomo, di che cosa ci è stato dato all’origine, che è la natura della nostra natura, che rimane intatta anche in lui. Affinché tu sappia, quando lo guardi, che ha dentro questo desiderio, che neanche lui sa consapevolmente. Solo se c’è qualcuno che lo guarda così, avrà la possibilità di vedere risvegliarsi tutta la densità del desiderio che ha dentro.
Che è quello che Gesù testimonia in continuazione. Va a casa di Zaccheo, e non si blocca a quello che pensano tutti. Tutti dicono: «Va a farsi ospitare in casa di un peccatore». Si potrebbe arrendere a quella evidenza, invece Lui sfida tutti, andando contro l’opinione di tutti! E succede quello che era inimmaginabile: quello sguardo è in grado di risvegliare talmente la coscienza, che Zaccheo comincia una vita nuova, zoppicando, a tentoni, come tutti noi. Cristo non ha ceduto a quello che pensavano tutti. Noi viviamo in una società come quella. Questo non significa giustificare, significa guardare l’uomo, la donna, il collega, il figlio, lo studente, con la stessa consapevolezza con cui noi ci siamo sentiti guardati. Perché, se noi non fossimo stati guardati così, noi, che eravamo nelle stesse situazioni di tutti, saremmo come tutti. Ma questo, invece di appesantirci, ci rende ancora più consapevoli della grazia che ci è capitata! E quindi possiamo vivere anche davanti a situazioni che non cambiano dal giorno alla notte, potendoci stare vivendo di questa grazia, aspettando il tempo dell’altro. Come Dio che vive talmente pieno del mistero della Trinità che può aspettare. Altrimenti, se uno non vive di questo, asfalta l’altro e gli butta in faccia tutto. Ma occorre molta più sovrabbondanza per non asfaltarlo e aspettare che raggiunga liberamente il suo compimento, che per asfaltarlo. Per asfaltarlo non ci vuole nulla, basta il vuoto. Per guardarlo così, occorre una sovrabbondanza! «Perché io (come mi domandano spesso) nel mentre cosa faccio?». Il problema è il “mentre”. Io di cosa vivo? Uno vive di una sovrabbondanza che ha ricevuto. Se noi non vivessimo di questa sovrabbondanza, cederemmo ad agire come tutti. Mi ha colpito quello che un amico mi diceva di recente: si sentiva ferito per una situazione, in cui aveva reagito come a volte ci si trova a reagire. Allora mi chiedeva che cosa dovesse fare, come doveva rispondere a questa ferita. Poi, a un certo punto, vive una serie di circostanze che lo riempiono di gratitudine. E non so perché, mi collega quel momento con la ferita. «In quel momento – dice – io non avevo bisogno di nessuna vendetta. Perché, perfino la vendetta era troppo poca rispetto a quello che io vivevo come pienezza!».
Il problema non è che dobbiamo essere coerenti: non è un problema di coerenza, non è un problema di volontarismo, non è un problema di energia, è un problema di sovrabbondanza. Queste circostanze, paradossalmente, ci portano a chiederci: qual è lo scopo della vita? Se lo scopo della vita non è il compimento, non è questa sovrabbondanza, noi agiamo come tutti. Invece, se lo scopo della vita per noi, in qualsiasi punto della strada siamo, è vivere sempre più di questa pienezza, ciò rende liberi noi, così da lasciare spazio libero agli altri, perché possano percorrere la strada secondo un disegno che non è il nostro. Se questo disegno non lo scoprono attraverso la libertà, non lo percepiranno adeguato alle loro esigenze, non sarà una pienezza loro! Se Dio avesse voluto, avrebbe posto sin dall’inizio delle leggi che si compiono meccanicamente, ma se fosse una legge meccanica, non la percepirei, dice Giussani, come una felicità mia, come una pienezza mia!
Come vedete, per poter parlare di un particolare, siamo costretti ad andare fino in fondo. E in questo le circostanze sono un fattore essenziale della nostra vocazione, perché la tentazione è di rimanere tutti nel seminato, cioè di non percorrere questa strada. Se tu non ti trovassi davanti a una sfida così – o ciascuno alle sfide che ha davanti – non saresti costretta a fare tutto il percorso tuo! Non lui! Il tuo collega dovrà fare il suo, ma tu, per stare davanti a lui senza asfaltarlo, senza bastonarlo, devi aspettare che raggiunga liberamente il suo compimento, perché possa essere percepito come compimento suo, altrimenti non resisteresti. Per questo, le circostanze, paradossalmente, sono un fattore essenziale della vocazione. In ogni circostanza, ciascuno ha la propria sfida, che rompe le scatole, o che lo fa imbufalire, o che gli tira fuori tutta la rabbia che ha dentro. E se questa fosse la strada attraverso cui, “attraverso cui” siamo costretti a camminare al destino?
Allora le circostanze uno comincia ad abbracciarle, ad amarle, non a subirle, e tutto diventa meno violento e più pacifico. Infatti, noi parliamo della pace, ma alla fine la violenza vince. Quando, prima delle vacanze ho chiesto ai miei studenti, per parlare del Natale: «Se voi aveste tutte le risorse possibili e immaginabili di cui pensate di aver bisogno per cambiare il mondo, da dove comincereste?». Immaginate la variegata quantità di risposte: la guerra, il mondo stesso, la fame, la casa… E se c’è qualcuno che resiste? La violenza si impone. Vedi da dove nasce la dittatura? Da un desiderio buono di cambiare il mondo! Ma siccome c’è chi resiste, la violenza si impone. Pensate al Natale. Sarà questo che potrà cambiare il mondo? Il metodo che Dio ha scelto sfida il nostro modo di pensare e di cambiare il mondo? Non è che celebriamo il Natale per fare non so quale fuga sentimentale. È una sfida alla nostra ragione, al nostro modo di stare nel reale. Se qualcuno fa il paragone tra quello che gli viene in mente per affrontare le circostanze e cosa ha fatto Dio, qualcosa occorre ancora imparare, mi sembra.
Intervento. Ti ringrazio Julián perché in parte hai già risposto, però io voglio chiederti un affondo sulla questione delle circostanze. Per me le circostanze sono molto sfidanti; mi sono capitati un po’ di fatti gravi che mi sfidano e non voglio perdermi il meglio. Mio fratello è in un momento di forte difficoltà e mi costa fatica stargli vicino. La sfida è doppia: riguarda il mio percorso e il suo, anche se per me, il mio viene prima. Ti chiedo una mano proprio su questo: come non censurare e come andare a fondo di queste circostanze? L’altro fatto che è capitato è la morte di mio cognato: la vita non ci risparmia le batoste. Però ci sono dei fattori belli; non che la morte di una persona cara sia bella in sé, però mi è successo di vedere un’amica tornata dal feretro, e qui presente, sorridente; è scesa dai gradini della camera mortuaria sorridendo. L’altro fatto è che mio fratello, pur dentro le sue enormi difficolta, pur essendo agnostico, mi ha detto che ha pregato, aggiungendo: «Mi ha aiutato, però devo essere coerente, non posso pregare solo quando ho bisogno». Io, subito, lo interrompo e gli domando:
«Ti è servito?». «Sì». «Questo basta». Vorrei essere aiutato sulla questione delle circostanze; non me le voglio perdere. A volte, quando sono con mio fratello, mi sento smarrito, ma non voglio eliminare lo smarrimento che provo, non voglio più mettere a posto le cose. Però voglio un aiuto, perché mi rendo conto che ho quest’occasione per crescere.
Julián. Chi te lo impedisce? Non perdertela, è facile.
Intervento. Per te è sempre tutto facile.
Non esiste niente di meccanico nella vita umana

Foto d’archivio
Julián. Mi ricordo una volta che, invitato a fare un dialogo con un gruppo di ragazzi prima dell’esame di stato, una ragazza dice: «Io voglio fare Medicina, ma non voglio perdere tutta l’estate per preparare il test che dovrò fare». Io, subito, ho tagliato corto: «Chi te lo impedisce? Vai in spiaggia!». Lei, subito risponde: «Ma io voglio fare medicina!». «Falla». È facile, capito? È come per te. A me quello che interessa è che in te, come nella ragazza che aveva poi passato il tempo dell’estate a preparare il test, si risvegli la voglia dal di dentro. Se io avessi cominciato a fare tutto il discorso, con tutti i passaggi, lei mi avrebbe lasciato parlare per un’ora e poi mi avrebbe detto che non l’avevo convinta. Conosco i polli del mio pollaio. Ma ad un certo punto – come dice un geniale teologo – uno per capire deve buttarsi. Se uno vuole veramente capire cos’è l’acqua, deve buttarsi nell’acqua. Non possiamo aspettare di capire che cos’è l’acqua senza bagnarci. Quindi, ci sono certe cose che si capiscono solo se ci si butta. Così è per te, come per me – questo per me è il fascino dell’avventura -: non possiamo capire se non buttandoci! E cosa vuol dire buttarsi? Che tu, davanti a tuo fratello, devi decidere come stare davanti a lui. Tu già sai di che cosa hai bisogno per stare davanti a lui, anche quando ti fa arrabbiare, o quando ti fa andare sulle furie, o quando vedi che ricade nei suoi guai, tu la strada la sai. Non devi essere performante; non siamo mai performanti! Perciò è facile: devi tornare al rapporto che ti genera.
È facile, come il bambino piccolo che va a quel rapporto che lo rimette a posto dalla fame, o dalla paura. È facile. La questione è che noi vogliamo la formula magica, la bacchetta magica, ma non esiste! Non esiste niente di meccanico nella vita umana, che è determinata dalla libertà. Io, facendo quella battuta a quella ragazza, le ho fatto emergere che si rendesse conto di quanto lei voleva studiare medicina, e sfidandola ad andare in spiaggia, se non voleva perdere il tempo nella preparazione del test! Ma, proprio in quel momento, lei si è sorpresa di quanto aveva voglia di iscriversi a Medicina; se noi, qualsiasi cosa facciamo, non ridestiamo nell’altro la voglia di fare il passo per il compimento, nessuna cosa lo convincerà! Per questo, in ogni provocazione di questo tipo, entra in gioco la tua libertà: la mia, quella della ragazza, quella del figlio. È facilissimo! Per il figlio dire alla mamma che ha fame è facilissimo. Ma noi non siamo così disponibili a questo: «No, ho bisogno di farlo io, non posso aspettarmi solo dal rapporto con un altro la risposta al mio bisogno». E allora tutto si complica! Non tanto perché sia complicato, ma perché noi lo complichiamo; il bambino non lo complica! Perciò Gesù pone come esempio il bambino: se non diventiamo come bambini, non entreremo nel regno dei cieli. Occorre smettere di dire che è difficile, perché, se è difficile, Gesù sbaglia quando dice che è un questione da “bambini”. Non è l’infantilismo stupido, è semplicemente il riconoscimento di che cosa ti rimette in sesto, ti rimette costantemente in un rapporto. Quando uno ha recuperato questo riconoscimento, poi ha l’energia affettiva per studiare durante l’estate, perché ha recuperato la ragione per studiare e preparare il test, anche se poi è stata bocciata.
Intervento. Voglio porre un problema. Devo essere molto sincera, perdonatemi per la sincerità. Io sono in Italia da ventinove anni, da quando mi sono sposata, e in questi anni ho costruito un’amicizia con delle persone: un’amicizia vera, fatta di rapporti in cui uno si gioca, va avanti, costruisce, insieme a ferite, pianto, allegria. Un anno fa, dopo che mio marito si è ammalato, ha partecipato ad una vacanza estiva con amici che non aveva mai frequentato, e per la prima volta, dopo tanti anni, l’ho visto contento, veramente contento. Mi sono sorpresa perché era da tanto tempo che non lo vedevo così. Insomma, c’è stato questo cambiamento in lui e io ho deciso di assecondare quello che è successo. L’assecondavo senza lasciare indietro niente, senza negare niente e buttandomi anch’io in ciò che stava accadendo a lui. Dopo tre anni, lui si è ammalato di nuovo e in questa circostanza l’ho visto cambiare ancora più profondamente, ho proprio avvertito la presenza di un Altro che lo cambiava. È entrato nel gruppo dei Quadratini, tra l’altro casualmente, e io, anche in questa occasione, ho continuato a seguirlo perché, dove guardava lui, c’era una possibilità anche per me, senza che fosse una teoria.
E così io, nel mio quotidiano tranquillamente vivevo, vivevo, ma mi sorprendevo anche di me stessa. Poi, è accaduto che, con gli amici che abbiamo da una vita, a cui io tengo molto perché con loro abbiamo costruito una storia, un cammino, tre settimane fa ho deciso di raccontare loro che cosa mi era successo. Perciò ho parlato loro dell’esperienza di cambiamento mia e di mio marito. Terminato il mio racconto, uno di loro mi ha corretto, ha voluto correggermi sulla mia esperienza, sul mio cambiamento. Io, poiché sono straniera, ho detto: «Boh, forse ho capito male». Però non avevo capito male, mi aveva corretto! Ma io ho avuto questa esperienza vertiginosa, vera e reale, che mi ha messo in movimento di più, fino a farmi arrivare al fondo di me stessa. Non ho capito tutto quello che mi è successo, e come tutti vado a tentoni, ma intuisco che cosa? Che quando si sperimenta una cosa del genere, non c’è possibilità di tornare indietro. Guardo dove c’è Lui, dove mi muove, dove c’è vita, dove io posso riconoscerLo e continuo a riconoscerLo; per meno di questo non vale la pena muoversi. Ci tengo ai miei amici, e loro tengono a me e al nostro rapporto, ma quando tento di spiegare loro cosa mi è successo, non riescono a capirmi. E qui io inciampo, perché nei rapporti umani a me interessa l’altra persona fino in fondo. Non mi faccio il problema di uno o dell’altro, so dove guardare, so dove andare e continuare ad andare. Ma quando loro mi chiedono… ci vuole tanta libertà e tanto amore a me stessa per poterli guardare e stare davanti a loro, anche se non capiscono.
Julián. Questo è stupefacente, e nel senso più bello del termine, perché quando succede una cosa di questo tipo, prima di tutto uno deve veramente andare a fondo di ciò che gli è capitato. Perciò hai ragione quando ti domandi: «Ma, è vero o non è vero? Ho capito o non ho capito che cosa mi è capitato?». Quindi, è parte del cammino che ciascuno deve fare con se stesso, per raggiungere la certezza di cui ha bisogno, per continuare ad aderire a quello che l’ha cambiato. Poi, quando uno comunica ciò, è normalissimo che l’altro possa non capirlo, come ti è successo. Ciascuno ha la propria strada. Il metodo di Dio è che non dà a tutti la sua grazia nello stesso tempo, e nello stesso momento storico. Tutti sappiamo che Dio agisce in modo tale che non dà a tutti la stessa grazia nello stesso momento. La dà a qualcuno per un altro. A cominciare da Abramo, perché Abramo è il segno di questo nuovo metodo di Dio. Riguardo al cambiare il mondo, quando sono andato l’anno scorso a Madrid ad un incontro a cui mi avevano invitato, sulla trasmissione della fede, a un certo punto mi sono fermato, dopo aver fatto questa domanda: «Vi do un secondo di tempo perché ciascuno pensi a come cambierebbe il mondo. Vi sfido, perché nessuno di voi sceglierebbe quello che ha fatto Dio: scegliere un uomo come Abramo per cambiare il mondo». Tutti erano d’accordo, ma nessuno l’aveva pensato. Quindi, nel metodo che Dio usa, proprio perché è l’unico rispettoso della libertà, viene data la grazia a uno per arrivare ad altri. Ciò che tu dici, io lo capisco. Dicevo ai ragazzi:
«Immaginate il cieco nato che torna a casa tutto contento, perché prima non vedeva e adesso vede. Si trova con un altro cieco, che conosce, e questi gli dice: «Sai, devo raccontarti una cosa stupenda, bellissima: mi hanno regalato un cane che mi guida per non sbattere contro il muro». Il cieco nato cosa potrebbe dire? «Mi rallegro tantissimo! Però non è lo stesso che vedere!». Però, come spieghi all’altro la differenza tra avere il cane e vedere? E se poi si trova davanti a un altro cieco a cui hanno regalato un bastone che gli impedisce di andare contro il muro, non può che essere contento! Come può spiegare a uno che non vede la diversità che a lui è capitata? Se io vedo, e lo dico a un altro, e l’altro non riesce a capire, dico: «Vai avanti! Goditi il tuo cane». Lo dico senza ironia: «A te è dato questo, vai fino in fondo, verifica quello che tu vivi». Non possiamo entrare in dialettica con quello che uno percepisce. Dobbiamo tifare per la libertà dell’altro: «Tu la vedi così? Vai fino in fondo! Sono felice! Perché, se tu non vedi quello che vedo io, io non posso importelo in nessun modo». Devo aspettare che l’altro lo veda, perché non c’è un altro accesso alla verità se non attraverso la libertà.
Torniamo sempre allo stesso punto; ciascuno deve fare la propria verifica, ciascuno per se stesso. Anche noi dobbiamo verificare la strada che stiamo facendo: quello che noi abbiamo riconosciuto come vero, ci riempie di vita o no? In questo senso vi ricordo il dialogo citato da Ratzinger tra il razionalista e quello che va a pregare; il «forse è vero». È sempre una dialettica tra il «forse è vero» e il «no». Saremo sempre così, ma intanto io dico all’altro: «Io sono felice che tu fai la tua strada, ma non posso rinunciare a quello che, totalmente, mi fa traboccare di pienezza». Occorre che ciascuno faccia la propria strada; se nel tempo, facendo ciascuno la sua strada, ci ritroviamo, benissimo, altrimenti ci troveremo nella vita eterna. Però io non posso rinunciare a quello che vivo e mi fa vivere, perché un altro non lo vede! Questo è il livello ultimo della persona che «la persona (dice Giussani), è rapporto con il Mistero», rapporto diretto con il Mistero. E ciascuno si gioca la propria partita. Ciò non vuol dire che, sapendo questo, tutte le volte l’azzecco; no, dovrò verificare io come ciascuno di voi, come l’altro. La responsabilità di ciascuno davanti al Mistero è personale, e, quindi, ciascuno decida. Qualsiasi strada che uno decide di percorrere per quello che gli è capitato nella vita ha bisogno di un paragone costante con l’esperienza elementare! Abbiamo letto nel capitolo quarto «immanente alla persona». Nessuno pensi che non possa imparare qualcosa di nuovo, non possa correggere qualcosa, siamo tutti allo stesso punto. Perciò, se il dialogo continua in questi termini, che ciascuno ama il cammino che il Mistero fa fare a lui e ama il cammino che fa fare agli altri, si può continuare. Sono in contatto con molte persone con le quali, essendo in cammini diversi, mantengo un rapporto assolutamente cordiale, pur nella diversa impostazione. Ma io tifo per la loro libertà, come loro rispettano la mia. Io cerco di essere me stesso con loro. Se c’è qualcosa di quello che io vivo che serve, benissimo, altrimenti, cerchino altrove. E lo stesso succede con chiunque di noi. Questa è la sfida che viviamo in questo momento, e può accadere ad ogni latitudine, può accadere con il collega, con gli amici, con l’ultimo che incontriamo per la strada. Un momento come questo è particolarmente sfidante. Noi abbiamo la fortuna, l’abbiamo per grazia, di aver incontrato don Giussani, di avere gli strumenti per giudicare: strumenti con cui il Mistero ci butta nella mischia. Possiamo approfittarne o possiamo essere in balia di tutti.
Intervento. (marito) C’è una cosa che mi urge, perché queste circostanze di cui stiamo parlando, nel nostro caso sono particolarmente dolorose, perché meno di un mese fa è mancato nostro figlio, dopo due anni di malattia. Due anni di malattia, nei quali abbiamo visto nostro figlio peggiorare di giorno in giorno. A volte, non nego che in una circostanza del genere mi viene da dire: «Cosa vuoi da me? E cosa vuoi da lui?». E tutte le armi, perdonatemi se sono un po’ duro, tutto il chiacchiericcio che 25-30 anni di vita di movimento, non servono. Quando qualcuno mi dice: «Il Signore manda una prova», penso che sia una bestemmia da confessare. Il Signore non può mandare una prova del genere a un ragazzo di diciannove anni, né a una famiglia, né può provare a insegnarci qualcosa attraverso un metodo del genere. L’esperienza che sto facendo è di portarmi dentro, da un lato un grande dolore, e, dall’altro, una grande rabbia. Cammino durante il giorno come se avessi una spada piantata nello stomaco, tutto il giorno così. Eppure, eppure, e qua mi collego a quello che dicevamo, dovrei essere profondamente sleale per negare che, attraverso questa vicenda, stanno succedendo delle cose incredibili. La testimonianza che mio figlio ha dato durante la malattia: nove giorni prima di morire, ha sostenuto due esami all’università, prendendo 30 in Meccanica e 26 in Statistica e, arrabbiandosi, perché non gli veniva l’esercizio durante il compito di Meccanica. È una cosa che a me ha fatto seguire mio figlio. Tante volte ho detto: «Mi sento figlio di mio figlio» per questa posizione che lui aveva.
Intervento. (moglie) Anch’io sono stata malata e ho dovuto fare la chemioterapia; nonostante la fatica, che anch’io conosco, mio figlio faceva tutto quello che gli era chiesto di fare e che doveva fare al massimo. Lui era educatore e il mercoledì, giorno della chemioterapia, si doveva riposare due ore per riuscire ad andare a fare l’educatore in oratorio. Lo stesso con lo studio: faceva fatica perché aveva l’ossigeno, eppure lui ha studiato fino all’ultimo.
Marito. È dura da accettare. Ho una grande domanda su di lui, ma, su di me, vedo quello che sta accadendo e ne resto stupito. Non nego che ogni tanto sono tentato di dire: «Tenetevele queste cose e ridatemi mio figlio!». Però, dall’Università, per esempio, ci arrivano lettere di ringraziamento da persone che non hanno mai conosciuto mio figlio e dai suoi amici, per come lui ha vissuto la sua malattia.
Moglie. È come se lui avesse insegnato a noi che il male, come diceva prima mio marito, esiste, ma non solo esso, perché siamo liberi, come dicevi tu prima, e Gesù c’è e ci sta dando tantissimi segni per dirci ciò. Lui si è stato male di notte, e il giorno dopo era il mio compleanno; le mie amiche non ne sapevano nulla, e mi hanno regalato una statuina del presepe che io adoro: si tratta di una mamma che porta sulle spalle il bambino per vedere Gesù. Quando mi hanno regalato questa statuina, e tuttora, nonostante io veda il bene, e i segni che il reale non inganna, la positività che da quel momento è nata, mi viene da dire: «Va bene, ma a mio figlio, Gesù, glielo voglio far vedere qua». Non possiamo dire di essere schiacciati dal dolore, e osservo persone che vedono la loro croce, non solo come un peso schiacciante. Ma, malgrado ciò, io vorrei che mio figlio fosse qui, pur avendo la certezza del Paradiso, e la certezza che lui è in Paradiso. Noi siamo del Movimento da tanti anni, lui invece era oratoriano, ma tanti ragazzi hanno notato che in questa vicenda non c’era solo disperazione. E qualcuno ci ha ringraziato perché pensava di venire a dire un rosario in una casa dove c’era solo disperazione: «Venivamo e pensavamo di vedere una sconfitta. Invece, abbiamo visto le migliaia di persone che c’erano e abbiamo visto che lui aveva un viso lieto». Nonostante fatti simili succedano ogni giorno, ne potrei raccontare a bizzeffe, tuttora a me verrebbe da dire: «Vorrei che fosse qui, vorrei vederlo qui … Invece non è così».
Marito. Riconosco, perché dovrei essere sleale come dicevo prima, che incredibilmente la realtà ha una nota di positività. E lo dico con la spada nello stomaco. Certo è una lotta riaffermare ciò. È una battaglia quotidiana che devo rifare ogni secondo, non ogni giorno, ma ogni secondo. Per mio figlio, quando era malato, hanno pregato da tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Russia, e non è servito a nulla, allora penso: «E, va bene, adesso voglio vedere che vinci, ora voglio vedere che vinci». Il problema è che poi mi rendo conto che mi faccio io le immagini di come Cristo dovrebbe vincere.
Julián. Perfetto. Ti stavo per chiedere questo: come sai tu se vince?
Marito. Come so se vince? Io ho le mie immagini, Julián.
Julián. Ma tu sei sicuro che questa immagine che tu hai sia la vittoria?
Marito. No, è esattamente contro ciò che devo lottare.
Julián. Il problema è usare fino in fondo la ragione. Innanzitutto, tu puoi dire che quello che hai visto è tutto, puoi mettere la mano sul fuoco che ciò che ti è successo è tutto?
Marito. No.
Julián. La sfida è alla ragione! Perché, se tu non puoi mettere la mano sul fuoco che quello che si vede è tutto, l’unica posizione ragionevole è lasciare aperta la categoria della possibilità. E se lei è convinta che lui è in Paradiso, che cosa vuole dire amare il destino del figlio più del nostro?! Godersi la pienezza che lui ora vive, o che ritorni per riempire il vostro vuoto? E se questa fosse la modalità attraverso cui il Mistero vi introduce a quel rapporto che già vostro figlio vive? Qui si gioca la libertà. Perché, non dico che Dio usi questo strumentalmente per altro, no. È che noi ci troviamo davanti a questa situazione. E questa situazione, lascia aperto tutto. Allora, la vera questione è se quando noi arriviamo ad una situazione come questa, possiamo lasciare aperta la ragione a questa possibilità, perché altrimenti dovrei dire che sono io il criterio per giudicare tutto quello che c’è o non c’è. E se questa fosse la modalità con cui il Mistero vi introduce alla totalità, perché non vi perdiate il meglio?! E recuperiate anche vostro figlio, alla grande, molto di più che se tornasse?! Perché, se non è questo, a me non interessa. Sarebbe semplicemente rimandare di qualche anno la vicenda, ma se non c’è altro, la sconfitta è di tutti: di voi e di vostro figlio. E se c’è altro, il figlio già partecipa della vittoria, e vi dice: «Ma, voi che cosa state a fare lì? Con il vostro modo di ragionare, invece di guardare come io già ora sto vivendo?». E aggiunge: «Perché perdete tempo?». Ciò non è meccanico, è una lotta, come dite, è una lotta e in questa lotta si gioca la partita, che non è da visionari, o da devoti. No, è di persone che sono veramente se stesse con tutta la loro apertura alla totalità della realtà, che è la ragione.
Quindi, più grande è la sfida, più grande è la messa in gioco della libertà, perché quanto più è grave quello che sta capitando, più è drammatico, meno è possibile tornare all’encefalogramma piatto, di cui abbiamo parlato prima. Quindi la circostanza è una circostanza essenziale per la vocazione! Perché il Mistero ha deciso di chiamarvi attraverso questa circostanza? Non lo so. Chiedetelo a Lui, quando arriverete. Ma, intanto, voi già vedete che questa circostanza è essenziale, adesso, per voi, per la vostra vocazione. E quindi, solo chi rischia potrà scoprire nell’esperienza, lasciando aperta questa possibilità, e vedere come la vita esplode o si affossa; questa è la lotta. E questo lo vediamo qua, non lo vedremo là. Lo vedremo qua. Quindi, non è che dobbiamo rimandare la vicenda a quando saremo di là … No, adesso, adesso. Perché, basta lasciare aperta questa possibilità che, attraverso questa crepa, comincia a introdursi una luce. Mi auguro che voi possiate vivere con tutti, come tutti; a noi non è capitato ciò che è capitato a voi, ma il nostro problema non è diverso dal vostro. Non è che voi siate più sfidati perché vi è capitato questo. Il mio problema, se io vivo all’altezza della mia ragione, è identico. Due settimane fa, parlando con una persona, mi racconta che lui era stato rifiutato da piccolo e mi dice: «Come si fa a vivere senza un padre, quando uno l’ha perso perché è stato rifiutato?» Gli dico: «Ma tu hai avuto altri padri?» risponde: «Sì». Gli dico: «È facile, trovando un altro padre. Se il Mistero ti dà la grazia di trovare un altro padre … Tu hai avuto un altro padre?». «Sì», mi dice. Però, mi ero dimenticato di dirgli la cosa più importante. Per caso, l’ho visto due giorni dopo e gli ho detto:
«Mi sono dimenticato di dirti la cosa più importante: anche se questo padre ti abbandonasse, c’è un Padre che non ti abbondonerà mai, ma proprio mai!». Inoltre, è rimasto di sasso quando ho detto: «A me non è capitato quello che è capitato a te. Ma il mio problema è uguale al tuo». Il problema è se c’è un Padre che non ci abbandona mai! Non conta il fatto che c’è un padre che ti ha abbandonato quando eri piccolo, il mio problema è adesso. Noi, e anche voi – lo avete potuto verificare – avete desiderato dare a vostro figlio tutta la pienezza. Però, la prima volta che l’avete avuto tra le vostre braccia, avete già intuito la sua grandezza, e, pian piano, vi siete accorti di tutta la vostra incapacità davanti alla sua esigenza di felicità. Quindi, la vera questione per ciascuno di noi è questa: se arriviamo a questo punto, a questa sfida così stravolgente. Potremmo non arrivarci, ma uno che non nega, o che ascolta quello che voi dite a tutti noi, si rende conto che questo è il suo problema. O quando gli capita di avere un istante di consapevolezza piena di sé, il dramma è lo stesso. Perché, se il dramma è risolto già adesso, è perché c’è un Altro. Il problema di vostro figlio è che è stato fortunato! Io sarei andato con vostro figlio. Perché? Perché so dove sta la vita, come dice San Paolo: «Per me vivere è Cristo e morire un guadagno». Voi non so cosa pensate, ma io, vi assicuro che avrei preferito andare con lui. Voi volete che ritorni a vivere? Rispetto la vostra percezione, ma io, se fossi al suo posto, vi direi: «Vi ringrazio papà e mamma, ma io rimango qua, aspettandovi!».
- Appunti non rivisti dall’autore
- Questo testo riporta una conversazione di un gruppo di amici avvenuta il 21 dicembre 2024
Legge anche: Cristo è lì dove accade

 3
3